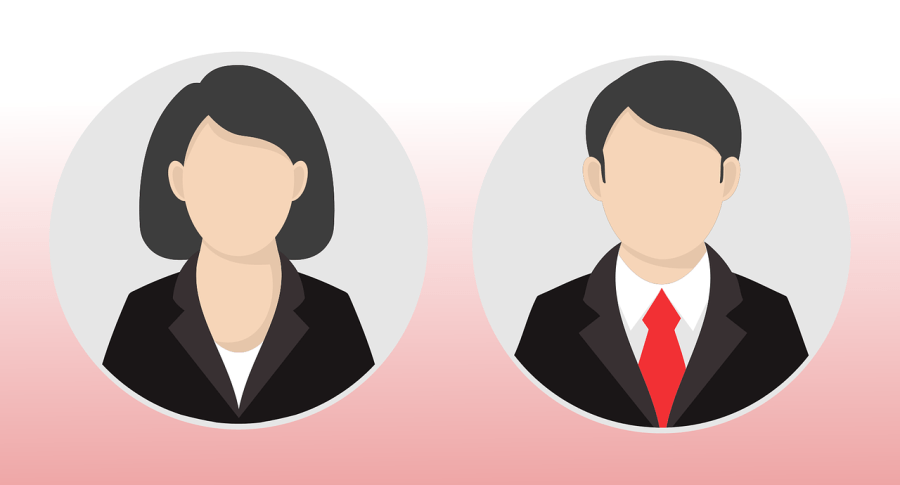Viviamo nell’era della comunicazione. È il grande business ed è anche la grande rete alla quale tutti siamo collegati come con un cordone ombelicale alla grande Mamma-Internet. Questo è un bene? Questo è un male? This is the question! direbbe Amleto.
Io non saprei. Dipende dai punti di vista e dai momenti nei quali è possibile osservare come si sviluppi il fenomeno della comunicazione, personale e globale. Ecco un paio di paradossi che sorgono, se si studia un po’ l’argomento.
Primo paradosso: non siamo mai stati così interconnessi, come specie, su questo pianeta, ma mai come ora la gente si sente sola e parla di solitudine.
Le emoticon, o emoji, ci aiutano a esprimere i nostri sentimenti nei messaggi su whatsapp o su facebook; lo schermo e il nikname anonimo che abbiamo scelto, ci proteggono dalla reazione immediata allo sguardo esterno a noi, così possiamo esprimere pareri azzardati o offensivi su twitter senza sentirci immediatamente toccati dal “ritorno” di quell’atto comunicativo verso gli altri.
Ma di persona cosa succede?
La maggiorparte delle persone si trasforma in analfabeta. È veramente difficile vedere conversazioni serene e rilassate, emotivamente aperte e fluide fra le persone, che si conoscano oppure no. Quando invece questo accade, per esempio in un programma televisivo o in un video su youtube, ciò crea una grande attrazione, perchè certamente è quello di cui abbiamo maggiormente bisogno. Questo potrebbe farci riflettere.
In compenso si moltiplicano le chat fra aspiranti suicidi, nelle quali ci si può anche fidanzare virtualmente, i siti di incontri dove si può mantenere segreta la nostra identità e fingerci altre persone, costruirci doppie vite, eccetera eccetera. E la comunicazione, quella autentica, quella da cuore a cuore, quella che è il nutrimento più goloso del nostro essere più intimo dove è andata a finire?
Secondo paradosso: se i pre-dialogali non ci sono, è impossibile comunicare realmente, se invece sono rispettati pienamente, basta un’occhiata per capirsi, non importa dirsi proprio niente.
Di cosa sto parlando? Delle condizioni previe al dialogo. Condizione numero uno: i termini che usiamo hanno lo stesso significato per entrambi gli interlocutori? Condizione numero due: siamo veramente sicuri che stiamo parlando dello stesso argomento? Condizione numero tre: il tema trattato ha lo stesso livello di importanza per ciascuno dei soggetti della comunicazione?
Comunicare, sul serio, non è una cosa semplice. In questa epoca la comunicazione si polarizza ogni volta di più. Ci si schiera subito fra i pro o i contro di qualsiasi cosa, e diamo per scontato tutta una miriade di sfaccettature che, se fossero prese in considerazione, renderebbero sicuramente molto più proficuo e ricco lo scambio. E forse ci farebbero passare dal pro al contro o viceversa.
La velocità di risposta, questa è la cosa più importante oggi. Essere veloci. E in quella velocità spesso perdiamo anche la consapevolezza del punto di vista da cui stiamo partendo, il nostro punto di partenza. Immaginatevi poi, come si possa riuscire a interpretare correttamente quello che dicono gli altri!
Per riflettere e imparare a comunicare realmente ci vuole un po’ di tempo. A volte non molto, giusto quello necessario e rimetterci in contatto con il nostro osservatore più profondo. Quello che vive in noi da sempre e da sempre ci guida in modo silenzioso, verso la nostra evoluzione e quella del nostro ambiente circostante. Questo non è banale, perché per riuscire a farlo dobbiamo aver avuto, in qualche momento della nostra esistenza, un’esperienza che ci abbia fatto prendere contatto con quell’osservatore. Altrimenti andiamo solo “di pancia” e ripetiamo le cose che ascoltiamo e che ci producono una sensazione piacevole nella pancia, appunto. Ma nella pancia vivono tutti i punti di vista, non quello che ci guida dal profondo, e lì si nascondono anche i nostri mostri più scellerati.
Alla fine, con o senza la comunicazione e la propaganda di massa, siamo sempre noi, con la nostra accuratezza e attenzione, a scegliere da chi farci guidare, a decidere chi o cosa vogliamo essere, a usare i mezzi di comunicazione in una direzione evolutiva oppure distruttiva.