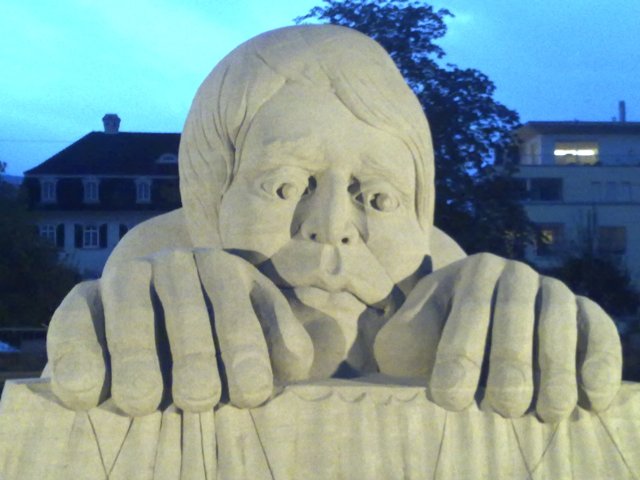I papaveri.
I papaveri accompagnano lo sguardo lungo i binari della ferrovia che corrono veloci. Ordinati e folti lungo i bordi erbosi.
Non come l’anno scorso, quando avevano invaso i campi seminati con enormi macchie vermiglie. No. Adesso sono degli accompagnatori discreti che rallegrano la vista dal finestrino del treno, con le loro teste scapigliate che ondeggiano al vento.
Il treno è asettico e pulito come non mai, l’odore di sottofondo del disinfettante mi fa venire il mal di testa. Ma i vetri delle ampie finestre portano ancora i segni essiccati di antiche piogge, e ne rubano la trasparenza.
Noi non ci guardiamo nemmeno. Noi passeggeri siamo distanziati e ognuno volge lo sguardo altrove: sullo smartphone, sulle pagine di un libro, fuori a correre coi papaveri. Ma non ci sono sguardi impauriti o tesi, semplicemente c’è spazio e ce lo prendiamo. Neanche il controllore ci guarda. Passa veloce e va, controllando a distanza non si sa cosa.
Esco dalla stazione e la cosa che mi colpisce di più è l’assenza di quel frastuono sordo di base che era prodotto dal traffico cittadino. Ci sono le auto, ma manca il sottofondo, si possono quasi distinguere una ad una con il loro particolare rombo. Poi le biciclette, non posso contare fino a 20 senza vederne una, qualche rider, molti semplici cittadini che hanno deciso di cambiare mezzo di trasporto. Ogni tanto il fischio del tram.

Ma spadroneggia il cinguettare degli uccellini impazziti per la primavera inoltrata e per quei raggi di un sole quasi estivo che risveglia i colori.
Le donne camminano con la mascherina fin sul naso, spesso di stoffa e con qualche dettaglio grazioso, un fiorellino applicato, una stellina ricamata, un tessuto colorato vivacemente. Gli uomini preferiscono tenerla sotto il mento mentre camminano, come me. La tiriamo sul naso ogni qual volta incrociamo qualcuno e quando la distanza con gli altri si riduce, è già quasi un gesto automatico, lento e sincronizzato.
Si cammina adagio. Anche i veicoli vanno lenti, si possono contare gli scooter che ci sono in giro, non come prima, quando sembravano una nuvola di moscerini impazienti e ronzanti.
E il verde, un verde rigoglioso ed esuberante…
Alla fermata dell’autobus solo una donna mi rivolge la parola e rompe il “muro” del metro distanziatore. Non ha quasi denti in bocca e la mascherina di stoffa è mezza su e mezza giù, rivelando una realtà che oggi avremmo l’opportunità di nascondere. Magrissima, porta con disinvoltura un ampio vestito colorato di un buon cotone, scarpe basse di tessuto a righe anch’esse di vari colori. Mi parla del suo cane che si è avvicinato, prima di lei, ad annusarmi le gambe, portatrici di innumerevoli e interessantissime informazioni. L’animale è di mezza taglia, biondo e gentile. Anche la donna è gentile e ha assoluto bisogno di parlare, la guardo negli occhi e vedo quella necessità estrema di un contatto normale e socievole, di specchiare la propria esistenza in quella degli altri. E allora non mi oppongo. Poco dopo vola via sul suo autobus che è arrivato, come una foglia colorata portata via dal vento autunnale.
Forse possiamo ancora fare qualcosa.
Forse possiamo curare la nostra società malata di ambizioni egoiste e insensibile ai bisogni essenziali. La pace, l’ascolto e l’aiuto reciproco, la sintonia e l’armonia con l’ambiente naturale.
Forse non è più tempo di correre.
Forse è arrivato il momento di imparare di nuovo a camminare e a guardarci intorno con soave curiosità.